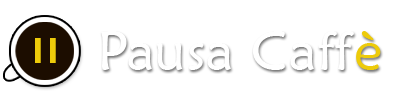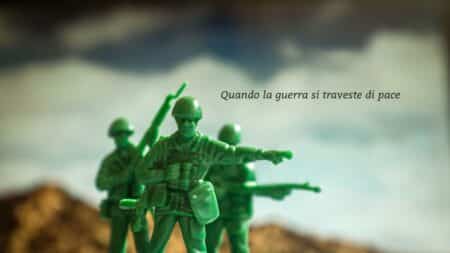È finito il pontificato di Papa Francesco.
Un percorso iniziato il 19 marzo 2013, quando Jorge Mario Bergoglio, il “papa venuto dalla fine del mondo”, dall’Argentina, saliva al soglio di Pietro. Un inizio che era già una dichiarazione di intenti: scegliere il nome di Francesco, il poverello di Assisi, era più che un omaggio. Era una scelta precisa, un manifesto.
Mai nessun Papa aveva osato quel nome.
Francesco, colui che aveva vissuto in totale povertà, in totale dedizione agli ultimi, in armonia con la natura e con ogni creatura. Prendere quel nome significava schierarsi, senza ambiguità: dalla parte degli ultimi, dei poveri, della terra stessa. Per Papa Francesco, l’essere umano è natura, insieme agli animali, alle piante: tutto parte della stessa grande famiglia creata da Dio. E il suo messaggio è stato, fin dal principio, un invito alla pace, al rispetto, alla tolleranza.
Ma il suo pontificato non si è svolto in acque tranquille.
Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, il Papa che aveva scelto l’abdicazione, un evento rarissimo nella storia della Chiesa, rimaneva figura ingombrante. Si è creata così una situazione inedita: due papi contemporaneamente presenti. Una parte della Chiesa, quella più conservatrice, quella che vedeva in Ratzinger il vero difensore della dottrina, non ha mai accettato davvero Francesco. Eppure, nonostante le critiche, Papa Francesco ha continuato per la sua strada, rivoluzionario nella sua semplicità.
Difesa della vita, certo, ma non solo quella dal concepimento alla nascita, discutibile, ma coerente ha difeso la vita in tutte le sue forme e in tutte le sue fragilità: la vita dei migranti, degli oppressi, delle vittime delle guerre, dei poveri. Ha condannato con forza il capitalismo sfrenato, la mercificazione degli esseri umani, lo sfruttamento selvaggio della natura.
Avrebbe potuto fare di più? Sì.
Pretendere che rovesciasse il tavolo sul diritto delle donne o sulle scelte sessuali degli individui era, forse, pretendere troppo. Poteva forse spingersi oltre, certo. Ma restava pur sempre un Papa, inchiodato a un magistero che su certi temi, aborto, diritti LGBT, resta ottuso e impolverato come un l’archivio vaticano stesso. Nonostante questo, ha provato ad aprire qualche spiraglio. Piccoli gesti, piccoli segnali. Non abbastanza per cambiare la storia, ma abbastanza per disturbare chi della chiusura fa il suo credo.
Un Papa ecologista, un Papa sociale, un Papa della dignità, che voleva rimettere l’economia al servizio dell’uomo e non del profitto.
La sua voce si è levata contro il traffico di esseri umani, contro i respingimenti dei migranti, contro i centri di detenzione disumani. Ma la politica, tanto a destra quanto a sinistra, lo ha usato più che ascoltato. Appellandosi a lui quando tornava comodo, ignorandolo quando le sue parole bruciavano troppo.
La destra si avvicinava a Francesco quando parlava di aborto o difendeva la famiglia tradizionale.
La sinistra applaudiva quando criticava i respingimenti o il capitalismo predatorio.
Ma entrambi lo tradivano nei fatti.
La politica non ha colto i suoi messaggi, anche di fronte ai drammi dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, ha scelto l’inerzia. Nulla è stato fatto, nulla è stato deciso. Eppure i suoi messaggi erano una chiara denuncia di un mondo del lavoro mercificato, precarizzato, umiliato, spesso responsabile di tragedie che strappano vite
Francesco è stato anche il Papa che ha voluto una Chiesa più pulita.
Ha condannato duramente la piaga della pedofilia, promuovendo l’avvio di procedimenti giudiziari rigorosi, ha avviato riforme finanziarie, ha attaccato i rapporti opachi della Banca Vaticana con l’industria bellica. Un Papa scomodo, anche dentro il Vaticano.
Un Papa che chiamava “genocidio” quello che accadeva in Palestina. Che implorava Putin e Zelensky di sedersi a un tavolo, mentre l’Occidente si armava fino ai denti. Un Papa scomodo, per questo inascoltato. Troppo impegnativo prendersi sul serio le sue parole su lavoro, carceri, immigrazione, pace. Meglio ridurlo a folklore: il Papa buono, il Papa simpatico, il Papa nonnetto che parla di amore e abbraccia i bambini. Applausi, selfie, zero conseguenze.
Papa Francesco, da giovane, era molto diverso: più cauto, più conservatore.
Durante la dittatura militare argentina, si era mosso con circospezione, tentando la sopravvivenza più che la sfida aperta. Non aderì pienamente alla Teologia della Liberazione, anche se ne comprese le istanze.
Ma col tempo maturò. Diventò sempre più sensibile ai temi della giustizia sociale, della dignità umana, della critica a un capitalismo disumano.
Giovanni Paolo II aveva visto il pericolo della mercificazione dell’esistenza.
Francesco raccolse quel testimone, ampliandolo: lottare per l’uomo voleva dire anche lottare per la natura stessa.
Le sue ultime parole sono state ancora un grido contro la guerra.
Un richiamo al dialogo, all’incontro, alla fine della violenza. Un grido che, ancora una volta, è rimasto inascoltato.
Un Papa del popolo, sì.
Populista? Forse, se populista vuol dire credere che gli ultimi abbiano più diritti dei primi. Se populista vuol dire pensare che un migrante sia un essere umano e non un problema. Se populista vuol dire non accettare che la croce diventi un’arma politica brandita da Salvini, Trump, Meloni o Vance. Perché, ricordiamolo, il cristianesimo è accoglienza, non respingimento; è solidarietà, non individualismo armato.
Un Papa perfetto? No. Ma umano Sì.
Oggi, mentre si volta pagina e si guarda al futuro della Chiesa, non possiamo che dirgli: grazie, Francesco.
Grazie per averci ricordato che il cristianesimo è comunità, è accoglienza, è speranza.
Che i migranti non sono clandestini, ma fratelli.
Che la natura non è una risorsa, ma una madre.
Morto un Papa se ne farà un altro, dice il proverbio.
Speriamo che il prossimo sia capace di portare avanti il sogno di un’umanità più giusta, più solidale, più umana.