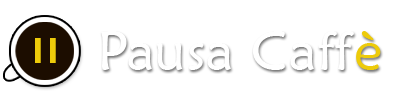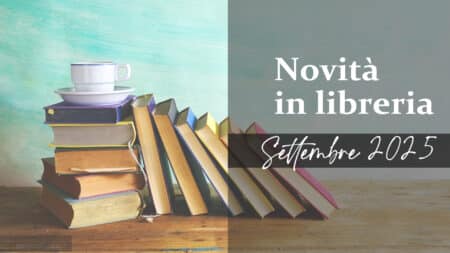Robert Langdon è un personaggio nato dalla penna dello scrittore americano Dan Brown, la sua prima apparizione risale al 2000, nel romanzo Angeli e demoni, da quel momento Langdon diventa il filo conduttore di storie dove simboli, enigmi e segreti custoditi da secoli si intrecciano con fatti storici e teorie suggestive, un terreno ideale per confondere ciò che è documentato con ciò che appartiene alla pura invenzione letteraria.
Langdon, almeno sulla carta, è un accademico rispettato, un professore di iconologia religiosa e simbologia ad Harvard, con un curriculum che sembra impeccabile. La sua formazione passa per la prestigiosa Phillips Exeter Academy, la stessa frequentata dal suo creatore, Dan Brown. Autore di titoli come La simbologia delle sette segrete, L’arte degli Illuminati e Il linguaggio perduto degli ideogrammi, Langdon appare come uno studioso capace di addentrarsi nei territori più oscuri e affascinanti del sapere.
Non stupisce, dunque, che nei romanzi venga spesso chiamato a decifrare simboli enigmatici e a fare luce su misteri che ruotano attorno a società segrete come gli Illuminati o il Priorato di Sion. Ma è qui che la finzione si intreccia con la realtà, i testi attribuiti a Langdon non esistono, e molte delle organizzazioni citate hanno più a che fare con la leggenda e la suggestione che con la storia documentata. È proprio in questo confine, tra ciò che sappiamo e ciò che ci piace immaginare, che nasce il fascino del personaggio.
“«Come ha fatto a trovarmi?» Langdon non riusciva a r ccapezzarsi e cercava di non pensare all’immagine del fax.
«Gliel’ho già detto. In Rete. Nel sito del suo libro, L’arte degli Illuminati.» Langdon provò a riordinare le idee. Il suo saggio era praticamente sconosciuto ne-
gli ambienti letterari ufficiali, ma si era conquistato un notevole seguito in Rete. “
Aspetto Fisico e Stile
Quando incontriamo Robert Langdon per la prima volta in Angeli e demoni, ha circa quarant’anni, non è l’archetipo dell’eroe affascinante alla maniera hollywoodiana, il suo aspetto colpisce più per ciò che trasmette che per lineamenti perfetti. Le colleghe parlano di lui come di un uomo dal “fascino dell’erudito”, alto un metro e ottanta, con capelli sale e pepe, occhi azzurri penetranti e una voce baritonale che sa farsi ascoltare.
“Pur non essendo bello nel senso convenzionale del termine, il quarantenne Lan-gdon aveva quello che le colleghe del gentil sesso definivano il “fascino dell’erudito”: folti capelli sale e pepe, penetranti occhi azzurri, suadente voce baritonale e sorriso grintoso e spensierato. Ex tuffatore nelle squadre studentesche del liceo e del college, Langdon aveva ancora la prestanza del nuotatore, con il suo metro e ottanta di statura e un fisico che manteneva in forma grazie a cinquanta vasche al giorno nella piscina dell’università.”
Dietro questa immagine c’è anche una disciplina fisica non scontata per un professore universitario. Ex tuffatore ai tempi del liceo e del college, Langdon mantiene la sua forma grazie al nuoto quotidiano, cinquanta vasche in piscina che gli restituiscono quella prestanza atletica che raramente ci aspetteremmo in un docente di simbologia.
Il suo stile, poi, diventa quasi un marchio distintivo, tanto che i romanzi lo descrivono come una sorta di “divisa”: giacca in Harris tweed, dolcevita antracite, pantaloni beige o cachi, mocassini eleganti. Eppure, l’elemento più curioso è forse l’orologio da polso di Topolino, non un semplice vezzo estetico, ma un cimelio d’infanzia donatogli dai genitori, che Langdon porta sempre con sé per ricordarsi l’importanza di “restare giovane dentro”, un dettaglio apparentemente minore, ma che contribuisce a rendere il personaggio più umano, più vicino al lettore.
“«Ho visto il tuo orologio quando eravamo sull’aereo.» Langdon arrossì. Era abituato a dover difendere il suo orologio con Topolino che segnava l’ora con le braccia, un pezzo da collezione che gli era stato regalato dai suoi genitori quando era bambino e l’unico orologio da polso che avesse mai portato. Subacqueo e fosforescente, era perfetto per nuotare e anche per guardare l’ora di notte nei viali bui del campus.”
Personalità e Abilità
Robert Langdon è una figura che vive di contrasti, da un lato ha qualcosa dell’uomo all’antica, con i suoi modi rigorosi e il suo abbigliamento sempre impeccabile, dall’altro sa essere moderno, capace di comunicare con leggerezza ed entusiasmo. Non sorprende quindi che i suoi studenti lo adorino, lo chiamano “il Delfino”, un soprannome che richiama tanto la sua indole scherzosa quanto la sua abilità in acqua, affinata tra tuffi e partite di pallanuoto.
La sua mente è un altro elemento che contribuisce a renderlo un personaggio memorabile. Langdon possiede infatti una memoria eidetica, una sorta di “fotografia mentale” che gli permette di immagazzinare e recuperare all’istante simboli, immagini e dettagli. È un tratto che lo rende perfetto per affrontare enigmi complessi e misteri secolari, ma che, nella realtà, appartiene più al mito che alla scienza. Ed è proprio in questo equilibrio tra plausibile e straordinario che Dan Brown ha trovato la chiave per trasformare Langdon in una guida irresistibile nei suoi romanzi.
“Nel fine settimana era facile vederlo bighellonare per il campus in jeans e discutere con gli studenti di grafica computerizzata o storia delle religioni, ma sulle riviste d’arte più autorevoli appariva in giacca di Harris tweed e gilet a disegni cachemire, immortalato durante le con-ferenze tenute alle inaugurazioni di musei e mostre. Benché come insegnante fosse rigoroso e piuttosto severo, era il primo a farsi a-vanti quando si trattava di divertirsi.“
C’è un dettaglio che rende Robert Langdon più vulnerabile, più umano: la claustrofobia. Una paura radicata nell’infanzia, quando cadde in un pozzo, un trauma mai del tutto superato, da allora evita gli ascensori, preferisce sempre le scale e ha scelto per sé una casa luminosa, piena di spazi aperti, non è un capriccio, ma la conseguenza tangibile di un’esperienza che continua a riverberarsi nella sua vita adulta.
Anche sul piano spirituale, Langdon appare sospeso tra due mondi, non si definisce credente, ma piuttosto uno studioso delle religioni. I miracoli lo lasciano “perplesso” e l’idea di un Dio che agisca come descritto dalle Scritture gli sembra difficile da accettare, eppure, ammette di desiderare la fede, la scienza, dice, lo porta a pensare che un dio debba esistere, ma la sua mente razionale non sarà mai in grado di comprenderlo davvero.
È in questa tensione, tra il bisogno di certezze e il fascino del mistero, che Langdon diventa un personaggio capace di riflettere le stesse domande che molti di noi si pongono, quanto c’è di vero nella fede, e quanto è invece un costrutto che ci serve per dare senso a ciò che non riusciamo a spiegare?
“«La vedo scettico» disse Kohler. «Pensavo fosse uno studioso di simbologia reli-giosa. Non crede nei miracoli?»
«Mi lasciano un po’ perplesso» rispose Langdon. E aggiunse tra sé: “Specialmente quelli che avvengono nei laboratori scientifici”.
«Forse “miracolo” non è la parola giusta. Stavo sol cercando di parlare nel suo linguaggio.»
«Nel mio linguaggio?» Langdon si sentì improvvisamente a disagio. «Non vorrei deluderla, signor direttore, ma io studio simbologia religiosa… Sono un docente universitario, non un sacerdote.»”
Vita personale e contesto
Robert Langdon vive da solo, in una grande casa vittoriana del Massachusetts. I colleghi scherzano definendola “un museo etnografico”, tanto è ricca di reperti e oggetti sacri raccolti nei suoi viaggi intorno al mondo. Non è soltanto la dimora di un professore, è una sorta di archivio vivente, dove ogni pezzo racconta storie, simboli e tradizioni lontane.
Nella sua vita, Langdon ama tre cose sopra ogni altra: la simbologia, la pallanuoto e, come lui stesso ironizza, il celibato, che gli assicura la libertà di viaggiare e dedicarsi senza vincoli ai suoi studi. La sua biografia sentimentale, infatti, è piuttosto frammentaria. In Angeli e demoni incontra la ricercatrice del CERN Vittoria Vetra, ne Il codice da Vinci è invece il turno di Sophie, la nipote del curatore del Louvre Jacques Saunière e in Inferno il professore conoscerà la brillante Sienna Brooks.
È curioso notare come le sue relazioni, sempre intense ma brevi, sembrino più funzionali alla trama che a un reale sviluppo del personaggio. Langdon, in fondo, rimane un viaggiatore solitario, un erudito che si lega solo per il tempo necessario a sciogliere un enigma, per poi tornare al suo mondo fatto di libri, simboli e silenzi.
“ho solo paura di restare da sola. “Io non ho questa paura” commentò fra sé Langdon. Le sue colleghe lo prendevano spesso in giro dicendogli che collezionava oggetti da museo per riempire un vuoto che, a loro dire, solo una donna avrebbe potuto veramente colmare. Langdon di solito ci rideva su e ribatteva che aveva già tre amori nella vita – la simbologia, la pallanuoto e il celibato -, e che quest’ultimo aveva il grande vantaggio di dargli la libertà di girare il mondo, dormire quanto gli pareva e godersi pacifiche serate casalinghe con un buon libro e un bicchiere di brandy.”
Il destino di Robert Langdon sembra quello di un uomo comune trascinato, suo malgrado, in scenari da prima pagina. Il suo coinvolgimento in eventi di enorme risonanza, come l’incidente in Vaticano narrato in Angeli e demoni, lo trasforma in una vera e propria celebrità nel mondo dell’arte e della cultura. All’improvviso, il professore di Harvard diventa una figura nota non solo agli studiosi, ma anche a un pubblico globale, affascinato dalle sue capacità di decifrare simboli e misteri.
Le sue avventure lo conducono in alcuni dei luoghi più iconici e carichi di storia, dai laboratori del CERN al Louvre, dal Campidoglio di Washington ai vicoli di Firenze, fino al museo Guggenheim di Bilbao. Ambientazioni che Dan Brown sceglie con cura, combinando il fascino del patrimonio artistico e scientifico con il brivido dell’enigma. E in ognuno di questi scenari Langdon si ritrova sempre al centro di trame oscure, con omicidi rituali, società segrete, complotti che intrecciano storia e leggenda.
In questo modo, il professore si muove su un terreno che gioca costantemente con i nostri limiti percettivi, quanto c’è di vero in quelle società segrete? Quanto invece appartiene solo al mito? È proprio in questa ambiguità che Langdon trova la sua forza narrativa, diventando una sorta di Virgilio moderno che ci guida nei labirinti del mistero.
“Si svegliò di soprassalto dall’incubo. Il telefono accanto al letto squillava. Sollevò la cornetta, intontito. «Pronto?» «Robert Langdon?» chiese una voce maschile. Langdon si tirò su a sedere nel letto vuoto cercando di schiarirsi le idee. «Sì, sono io…» Diede un’occhiata alla sveglia digitale. Erano le cinque e diciotto del mattino. «Devo vederla immediatamente.» «Con chi parlo?» «Mi chiamo Maximilian Kohler. Sono un fisico delle particelle.» «Come, scusi?» Langdon era confuso. «È proprio sicuro di voler parlare con me?» «Lei insegna iconologia religiosa all’università di Harvard, giusto? Ha scritto tre libri sulla simbologia e…» «Ha idea di che ore sono?» «Mi perdoni, ma vorrei che lei vedesse una cosa. Non posso discuterne per telefono.» A Langdon sfuggì un borbottio irritato. Non era la prima volta che gli accadeva: scrivere libri sulla simbologia religiosa comportava, fra l’altro, ricevere telefonate di fanatici a caccia di conferme sull’ultimo segno ricevuto da Dio.”
Il nome di Robert Langdon non è frutto del caso. Dan Brown lo ha preso in prestito da una persona realmente esistita, John Langdon, professore di tipografia alla Drexel University. John Langdon è un maestro degli ambigrammi, scritte che possono essere lette da più angolazioni, sia da destra a sinistra sia capovolte. Uno dei suoi ambigrammi compare addirittura sulla copertina della prima edizione inglese di Angeli e demoni.
Nella pagina dei ringraziamenti, Brown definisce Langdon «uno dei più ingegnosi artisti viventi […] che ha risolto brillantemente la mia sfida impossibile per creare gli ambigrammi presenti in questo romanzo». Ma il contributo di John Langdon va oltre i libri, ha realizzato anche il logo della Depository Bank of Zurich, che appare nel film Il codice da Vinci.
Questa connessione tra realtà e invenzione non è un dettaglio da poco. Il personaggio di Robert Langdon nasce proprio da un incontro tra fantasia narrativa e geni del mondo reale, sottolineando come la linea tra ciò che esiste e ciò che immaginiamo possa essere sottile, un tema ricorrente nelle avventure del professore.
Sul grande schermo, Robert Langdon ha preso vita grazie a Tom Hanks, che lo interpreta nei film tratti dai romanzi di Dan Brown, Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, tutti diretti da Ron Howard. L’attore riesce a dare corpo e presenza a un personaggio che, sulla pagina, è insieme studioso, investigatore e viaggiatore, trasformando il professor Langdon in un volto familiare per milioni di spettatori in tutto il mondo.
Nella televisione, invece, Robert Langdon prende vita nella serie Il simbolo perduto, tratta dall’omonimo romanzo del 2009 di Dan Brown. Prequel della saga cinematografica, la serie vede Ashley Zukerman nei panni del protagonista, offrendo una nuova interpretazione del celebre professore e approfondendo aspetti della sua vita e del suo lavoro che i film non avevano il tempo di esplorare.
Romanzi con Robert Langdon
2000 – Angeli e demoni (Angels & Demons)
2003 – Il codice Da Vinci (The Da Vinci Code)
2009 – Il simbolo perduto (The Lost Symbol)
2013 – Inferno
2017 – Origin
2025 – L’ultimo segreto (The Secret of Secrets)
Il blog è affiliato ad Amazon quindi cliccando sui miei link e acquistando percepirò una piccola commissione che utilizzerò per gestire il blog e comprare libri.