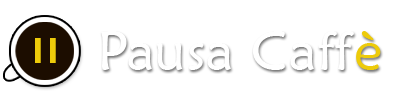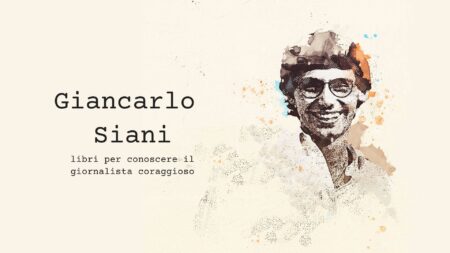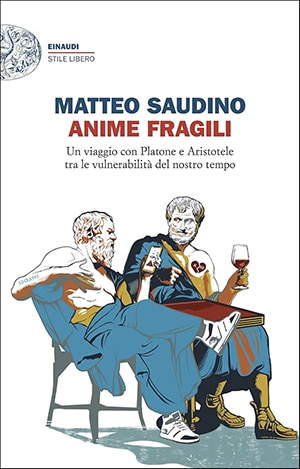
“Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo” è l’ultimo libro di Matteo Saudino, il professore di filosofia che ha conquistato il cuore di adulti e ragazzi. Creatore del seguitissimo «BarbaSophia», Saudino si cimenta in questa nuova opera, pubblicata il 22 aprile 2025 da Einaudi, con un’approfondita riflessione sulle fragilità dell’umanità moderne, guidando il lettore attraverso il pensiero dei due giganti della filosofia, Platone e Aristotele. Un percorso che promette di offrire nuove chiavi di lettura delle sfide e delle vulnerabilità del nostro tempo, sempre con la sua capacità di rendere la filosofia accessibile e stimolante.
«La filosofia arricchisce e abbellisce l’esistenza umana, rendendola piú degna d’essere vissuta».
Il nostro è un tempo con poche certezze e tante cose che non funzionano piú. Una fase storica in cui è difficile orientarsi. Dalla solitudine alla mancanza di dialogo, dall’assenza di verità alla crisi della politica, passando per le inquietudini della tecnologia e il tabú della morte, sono tante le vulnerabilità con cui ci ritroviamo a fare i conti. Per questo, in un mondo in continuo mutamento, la filosofia, a scuola e nella vita, resta uno strumento di comprensione indispensabile e affascinante. E Platone e Aristotele, i due massimi pensatori dell’antichità, possono aiutarci ad affrontare le paure dell’Occidente.
«Oggi Platone e Aristotele sono due bussole per navigare i mari della fragilità, nel tentativo di trovare o dare un senso alle nostre esistenze, e per provare a vivere liberi e felici»
Questa sarà la mia prossima lettura. Seguo il Professore Saudino da tempo e, ogni volta, riesce a catturarmi completamente, riuscendo nel suo intento di rendere la filosofia accessibile a tutti. È grazie a lui, infatti, che ho intrapreso letture che mai avrei pensato di affrontare, come Così parlò Zarathustra di Nietzsche. La curiosità mi ha spinta poi a leggere anche Il Manifesto del Partito Comunista, per farmene un’idea personale, anche perché mio nonno ne parlava spesso. Ho anche letto il suo precedente libro, La filosofia non è una barba. Fino a ora, ho potuto leggere solo l’anteprima di Anime Fragili, ma già mi sono trovata a voler sottolineare quasi tutto, se la premessa è questa, temo che sarà difficile tenere la matita ferma.
Recensione
Ho finito di leggere questo saggio breve ma intenso che unisce storia personale, filosofia classica e riflessione sul tempo attuale e Saudino coinvolge come nei suoi video. Come ho previsto nella segnalazione che fatto per l’uscita del libro, ho sottolineato mezzo libro, non posso divulgare tutte le citazioni che vorrei, rischierei una denuncia.
In un mondo che sembra perdere ogni giorno un pezzo di sé, in un contesto di smarrimento, può sembrare quasi strano, perfino fuori luogo, tornare alla filosofia antica in cerca di risposte, eppure è proprio da lì che parte questo saggio, non con la nostalgia di chi guarda al passato con rimpianto, ma con la curiosità autentica di chi cerca strumenti per capire il presente.
Il professore non si limita a elencare problemi astratti, parla di crepe reali, che tutti, in un modo o nell’altro, sentiamo, come la solitudine che scava dentro, la politica che non ci rappresenta più, la verità che sembra sfuggirci e la morte, sì, la morte, rimossa, taciuta, eppure sempre lì, sullo sfondo. Sono ferite sottili, invisibili, ma non per questo meno dolorose, e forse è proprio il silenzio con cui le trattiamo a renderle più pericolose, continuando a pulsare sotto la superficie delle nostre giornate.
Ed è qui che entrano in scena i due giganti della filosofia greca: Platone e Aristotele. Due nomi che sembrano lontani anni luce, e che invece, letti oggi, parlano con sorprendente chiarezza. Platone ci invita a guardare oltre le apparenze, a cercare il senso profondo delle cose, a riscoprire il valore del dialogo e dell’amicizia come legame che ci eleva. Aristotele, più terreno, ci ricorda che la politica può (e deve) essere qualcosa di nobile, che la virtù è una pratica quotidiana, che l’anima non è un concetto astratto ma il centro pulsante di ciò che siamo.
“Se la filosofia è una cassetta degli attrezzi per orientarsi nella complessità della realtà, allora ecco che Platone e Aristotele sono la chiave a stella e il cacciavite per decodificare il mondo e per provare ad affrontare le tante fragilità che lo caratterizzano.”
Nel libro vengono analizzate diverse “fragilità” del tempo presente, la prima grande fragilità di cui ci parla è la solitudine. Paradossalmente, in un’epoca in cui siamo più connessi che mai grazie ai social media, viviamo quella che si può definire una vera e propria “Grande Solitudine”, figlia di una società sempre più individualista che ha frammentato le persone, spezzando il tessuto delle relazioni collettive. La nostra identità sembra costruirsi sempre di più sul consumo, quasi come se il nostro valore dipendesse da ciò che possediamo o acquisiamo. Ma qui, Platone e Aristotele ci offrono una via diversa: la riscoperta della bellezza vitale dell’amicizia. Riscoprire questa dimensione, fatta di cura, di attenzione autentica verso l’altro, può essere una delle chiavi per rompere l’isolamento e combattere l’individualismo che ci ingabbia.
La seconda fragilità che attraversa la nostra epoca è la mancanza di vero dialogo. Nonostante siamo sommersi da una quantità infinita di mezzi di comunicazione e da un flusso continuo di informazioni in tempo reale, la comunicazione resta spesso superficiale, usa e getta, schiava della logica del profitto e dell’intrattenimento facile. Il risultato? Un’epidemia silenziosa di analfabetismo funzionale, alienazione, ignoranza e, soprattutto, una crescente paura di prendersi responsabilità. Le grandi narrazioni collettive, che una volta davano senso e direzione alle nostre vite, sono in crisi. Al loro posto si sono imposte piccole storie individuali, consumistiche e frammentate, che non riescono a costruire un vero legame sociale. A differenza della parola scritta, rigida e immutabile, il dialogo orale è vivo: si adatta, si contamina, si trasforma nel confronto con l’altro. È un antidoto prezioso contro l’anonimato, la deresponsabilizzazione e la pigrizia intellettuale che spesso dominano la comunicazione digitale di oggi. Coltivare il dialogo, riscoprire l’oralità, significa quindi aprirsi a un pensiero critico più solido e a relazioni più profonde, un passo fondamentale per uscire dall’isolamento mentale e costruire insieme un futuro più consapevole.
“Ammettere la propria ignoranza è quanto di piú elevato si possa fare, perché è l’inizio di una vita all’insegna della meraviglia, della curiosità e della scoperta. Il sapere di non sapere ci colloca a metà tra la divinità che tutto sa e lo stolto che tutto è convinto di sapere anche se poco o nulla sa: a entrambi, per motivi opposti, è negata la bellezza del dolce e illuminante naufragare nella filosofia.”
La terza fragilità che ci mette in crisi è quella della politica. Oggi sembra svanita, quasi sparita dalla nostra vita quotidiana, percepita come qualcosa di inutile, corrotta, lontana dai veri bisogni della gente. La politica è diventata una serva dell’economia, disumanizzata, ridotta a un prodotto da vendere, come se fosse solo una merce. Valori fondamentali come la solidarietà e la giustizia sembrano reliquie di un tempo passato, ormai dimenticate. Ma Platone e Aristotele, che hanno visto l’essere umano come un animale politico e sociale, ci offrono ancora oggi una bussola preziosa. La comunità politica è qualcosa di naturale, e far parte di essa significa partecipare attivamente, sia nelle responsabilità pubbliche che nei diritti. Riscoprire questa dimensione politica profonda, valorizzare il senso di partecipazione, è essenziale oggi, soprattutto in un momento in cui la democrazia è minacciata da poteri economici che sembrano quasi feudali e da forze demagogiche che giocano con la paura.
“per Platone è impossibile vivere bene in una città retta da leggi ingiuste e governata da politici corrotti, perché l’ingiustizia non si ferma sull’uscio delle case: ne sfonda le porte, entra e travolge le vite degli individui, delle coppie e delle famiglie. Nessuno può sfuggire alla malapolitica. Per questo la felicità non è mai solo una faccenda privata, ma sempre pubblica. E noi oggi dobbiamo recuperare tale prospettiva, perché pensare che le questioni politiche riguardino le vite degli altri e non la nostra è un’illusione che ci rende complici delle ingiustizie e meri spettatori dei processi decisionali che guidano le comunità in cui viviamo.”
La quarta fragilità che attraversa i nostri tempi è la fine della Verità, o meglio, il suo dissolversi in un mondo dominato dalla post-verità. Oggi è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, perché le certezze assolute si sono sgretolate e ha trionfato un’idea: “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Questo relativismo, che ci ha liberati dai fondamentalismi più rigidi, ha però spalancato le porte al nichilismo, a un senso di vuoto e smarrimento. In un’epoca come la nostra, in cui falsificazioni e manipolazioni ci assediano ogni giorno, allenare il ragionamento corretto diventa un’arma fondamentale. È il modo migliore per attraversare con consapevolezza le fragilità del nostro tempo e non cadere vittime delle bufale.
“Il platonismo è un inno alla ricerca della verità, la quale è faticosa, ma è anche ciò che eleva l’essere umano facendogli spiccare il volo verso l’alto, dove risiede la bellezza. Il vero è dunque una meta, un limite a cui tendere, viaggiando verso il quale noi esseri umani ci trasformiamo: privati della voglia di superare i confini, di metterci in gioco, siamo destinati a rimanere bozzoli senza mai liberare la farfalla che è in noi.”
La quinta fragilità che ci tocca da vicino è l’inquietudine della tecnologia. Non c’è dubbio che l’innovazione abbia migliorato molte condizioni materiali della nostra vita, ma insieme a questo progresso ha portato con sé paura, smarrimento e una relazione complicata, quasi di amore e odio, tra l’essere umano e la macchina. Spesso riponiamo nella tecnica la speranza di una salvezza, ma la tecnologia da sola non dà senso all’esistenza; anzi, a volte ci rende più fragili e disorientati. La questione della tecnologia è quindi profondamente politica: chi la controlla e per quale scopo? Senza una classe politica capace di lungimiranza e una cittadinanza attiva che punti alla giustizia e alla cooperazione, la tecnologia rischia di diventare uno strumento di dominio e oppressione. La tecnologia, quindi, non può essere lasciata al caso o al puro profitto, deve essere governata da scelte etiche e politiche, per servire la crescita umana e non diventare uno strumento di controllo o esclusivo dominio. “La conoscenza nasce dalla meraviglia.”
“Ma noi, oggi, riusciamo ancora a meravigliarci, oppure l’età della fragilità, cosí veloce e mercificata, ha offuscato questa esperienza? Per che cosa un ragazzo o una ragazza, in primis occidentali, si sorprendono? Anche in questo caso, vivere nell’epoca della velocità e della sovrabbondanza di stimoli, immagini, suoni e beni materiali finalizzati al consumo rapido e senza sosta, meglio ancora se compulsivo, non favorisce il sentimento di stupore di fronte al mondo. Persino morte, violenza, catastrofi naturali e guerre sembrano non suscitare particolare interesse, finendo nel grande calderone degli eventi consumati e gettati via senza essere vissuti”
La sesta fragilità riguarda la rimozione della morte nella nostra società. Viviamo in un mondo che celebra la felicità a ogni costo, dove il dolore e la morte diventano tabù da evitare, perché minacciano quel ritmo frenetico e consumistico che domina il nostro tempo. Ma questa fuga dalla morte ci conduce a un’esistenza superficiale, priva di autenticità e significato. Accettare la morte come una possibilità sempre presente è la chiave per vivere autenticamente, solo così si può davvero cercare e dare senso alla propria vita.
“Vivere in un presente senza morte trasforma le persone in replicanti del nulla, che occupano uno spazio e un tempo privi di significato. La rimozione della morte, del limite umano, in nome della dittatura di un eterno presente sempre piú edonistico, frenetico, compulsivo e ossessivo, ha prodotto l’illusoria immortalità di un essere umano che nel consumare per consumare e divertirsi per divertirsi si scopre ogni giorno piú fragile. “
Questo libro non pretende di offrire soluzioni pronte, ma indica una direzione, riscoprire la filosofia non come un esercizio da aula universitaria, ma come uno strumento per leggere meglio il mondo, per orientarsi nell’incertezza, perché, in fondo, ricominciare a pensare è forse il gesto più radicale e necessario che possiamo fare oggi. Un modo per tornare a vivere in maniera più vera, più consapevole, e, perché no, più umana.
Lo consiglio a chi è curioso della filosofia antica ma teme testi troppo accademici, a chi si sente smarrito nelle contraddizioni del presente e cerca strumenti che parlino sia alla ragione che al cuore, a chi finalmente si vuole sentire capito e meno solo, va bene per studenti, insegnanti e genitori, insomma dovrebbero leggerlo tutti.
“Fare della scuola un grande laboratorio di ricerca e di sperimentazione, in base all’età degli allievi e in ogni campo del sapere (matematico, linguistico, artistico, tecnico, scientifico, storico e filosofico), è forse il modo piú efficace per dare ai giovani gli strumenti pratici e critici per attraversare le molteplici faglie di fragilità che caratterizzano il nostro tempo.”
Citazioni dal libro Anime fragili
“il presente divora il passato: è l’ineludibile divenire del tempo che travolge ogni cosa. I mondi nascono e muoiono, si trasformano, si contaminano, si scontrano, a volte implodono o esplodono, altre volte cercano con tenacia mista a inconsapevolezza di protrarsi nei nuovi mondi che sorgono.
La legge di Eraclito, l’oscuro filosofo di Efeso, tutto scorre (panta rei), è probabilmente l’intuizione più lungimirante e veritiera della filosofia occidentale: se la realtà ha una legge, tale legge è il divenire incessante della realtà stessa, causato dall’eterno scontro degli opposti (caldo-freddo, salute-malattia, giorno-notte). La bellezza eclettica dell’arcobaleno ha origine dal turbamento del temporale, proprio come lo splendore del sorgere del sole nasce dal suo crepuscolo, la salute dalla malattia e la gioia dalla tristezza. Gli opposti che si scontrano e si completano sono alla base del divenire della natura e dell’equilibrio ciclico di nascita e morte: la primavera si scioglie nell’estate, che è divorata dall’autunno, il quale a sua volta è ucciso dall’inverno che lento muore nella primavera: questa può rinascere e sbocciare di nuovo in tutta la sua bellezza, e cosí via. Un ciclo eterno e infinito.”“Tutto muta, tutto danza nel cambiamento, nulla è per sempre uguale a sé stesso, nemmeno un diamante. Gli esseri umani sono in mutazione permanente: oggi non sono quello che erano ieri né quello che saranno domani. Da nessun punto di vista: fisico, emozionale, intellettuale. Le stesse comunità umane sono un prodotto storico, culturale e sociale in costante mutamento. Società nomade / stazionaria, società politeista / monoteista, società feudale / capitalista, società religiosa / laica, società analogica / digitale.
La grande e radicale novità però dell’incessante divenire del nostro mondo risiede nel fatto che a partire dalla rivoluzione industriale, e in particolare nel corso del Novecento, i cambiamenti sono sempre piú rapidi e frenetici e sempre piú importanti e impattanti nelle vite delle singole persone e delle comunità umane. I mondi da sempre cambiano, solo che oggi nascono, mutano e muoiono in modo ultraveloce.”
” E oggi che Dio è morto e sepolto, sostituito da vitelli d’oro quali denaro, cellulari, successo e cinico individualismo, regna un profondo e doloroso disorientamento in cui è difficile capire se si sta percorrendo la strada giusta o quella sbagliata. Il senso del vivere e del mondo appare impossibile da trovare, al punto che molte persone sembrano rinunciare a cercarlo. La terra sotto i piedi è instabile e frana, quasi non si riesce a distinguere cosa è giusto da cos’è sbagliato. Chi lo stabilisce? E poi vale per ciascuno di noi? La morte di Dio ha smascherato la favola millenaria del bene e del male come valori assoluti da seguire o da imporre e ha messo in discussione il regno di Apollo, che tutto ordina in modo razionale e funzionale, reprimendo la danza emozionale e liberatoria di Dioniso. ”
“Oggi Platone e Aristotele, come due Prometei liberati dalla loro pretesa di fondare un sistema filosofico totale, in cui ogni cosa è spiegata e collocata sempre nel posto giusto al momento giusto, in un mondo dunque post platonico e post aristotelico, post Dio e post Verità assoluta, un mondo per molti aspetti post tutto, sono due bussole per navigare i mari della fragilità nel tentativo di trovare o dare un senso alle nostre esistenze, per provare a vivere liberi e felici. Non si tratta di un ritorno nostalgico ai due filosofi dell’antica Grecia, bensí di interrogarli alla luce dello spirito del nostro tempo. Io sono pronto, Platone e Aristotele anche: che il viaggio abbia inizio.”
“Oggi noi, liberati dalla forza rassicurante degli dèi onnipotenti, dei padri padroni, dello Stato condottiero, della famiglia perfetta, del mercato infallibile e dalla pretesa di protezione di ogni altra neo e post divinità (tecnologia, social, consumo e denaro in primis), ci scopriamo anime fragili ma libere, sempre in bilico tra paure e speranze, con in mano la responsabilità di scrivere il nostro destino. Magari solo a matita, ma è la nostra matita, e non una lussuosa penna stilografica nelle mani di un re o un dio. Dio è morto, non torna, ma in quel vuoto, senza nostalgia, possiamo dipingere l’orizzonte del nostro vivere.”
“Saper dialogare, infatti, non significa solo comunicare in modo aperto, ma implica soprattutto essere disposti ad ascoltare i punti di vista degli altri e a mettere in discussione le proprie idee. Dialogare significa rinunciare a essere i detentori di una verità assoluta, e questo atteggiamento filosofico educa al rispetto e contrasta i fanatismi di ogni sorta, da quelli politici a quelli religiosi, ancora radicati nelle nostre società.”
“In un mondo fondato sulla quantificazione e la misurazione di ogni aspetto della vita (voti, prezzi, iban, polizze assicurative, numero di follower, visualizzazioni, Like, cuoricini) l’essere umano si trasforma in un numero tra i numeri. La numerificazione dell’esistenza umana è un processo di alienazione che svuota e divora le persone. La logica produttivistica e utilitaristica che regola i rapporti economici è diventata la logica che regola le relazioni umane e sociali: si è passati dall’economia di mercato alla società di mercato, dall’essere umano come animale politico all’essere umano come animale economico. Tale passaggio ha via via trasformato ogni aspetto della vita in una competizione che crea frustrazione e senso di inadeguatezza. Se hai, sei. Se appari, sei. Se conti, sei. Se non hai, non sei. Ma ogni costruzione dell’essere che si fonda sull’avere è precaria, carente di senso, e per questo destinata a generare insicurezze e a precipitare in angoscianti fragilità. ”
“Platone vuole comunicare anche che l’arte della politica è la piú importante di tutte in quanto permette agli esseri umani di vivere insieme. Senza di essa la tecnica, la forza, la creatività sono fragili: la politica è la loro conditio sine qua non. Ecco un problema della fragilità del nostro tempo: pensare che la politica sia inutile, che occuparsene sia una perdita di tempo o che il professionista della politica sia un riferimento importante solo quando si ha bisogno di un favore.”
“Se sei povero è colpa tua! Ogni dimensione politico-collettiva che ambisce a cambiare le cose viene ridicolizzata, messa al bando, presentata come ingenua e irrealizzabile: la società deve essere un luogo asettico e immodificabile, da accettare; in cui al massimo cercare di realizzare i propri desideri individuali, primeggiare, lottare per emergere o per sopravvivere: ognuno per sé in una corsa verso il successo personale.
Prestazione, merito, volontà: il mondo è dei piú forti. Dunque, se vivi in un contesto di povertà economica, insoddisfazione professionale, frustrazione scolastica, la colpa è solo tua, in quanto incapace di metterti in gioco, debole e privo di volontà, di spirito imprenditoriale, tenacia, disciplina, autocontrollo. Questa nuova narrazione, presentata come post ideologica – ma che è solo una subdola ideologia che rafforza il potere dei soggetti dominanti –, ha suscitato, soprattutto nelle nuove generazioni e nelle classi popolari, un sentimento di rassegnazione, insicurezza e paura.”
“Il demagogo è una figura della politica che ha attraversato i millenni con le sue vane promesse, con il suo dire al popolo quello che il popolo vuole sentirsi dire, con il suo gridare ai quattro venti «VOTATEMI, SONO COME VOI e farò i vostri interessi!» Invece i cittadini dovrebbero forse dire: «Non voglio votare uno come me, ma qualcuno che sia migliore di me, anche di poco!»”
“La democrazia per noi è il migliore dei sistemi politici, o comunque il meno peggio, ma affinché funzioni bene servono cittadini preparati e istruiti alla vita democratica. Per questo, cogliere la politicità di ogni aspetto del nostro vivere (studiare, mangiare, andare in vacanza, scrivere un post, pubblicare una foto, guardare una serie tv o passare ore al cellulare) aiuta ad acquisire la consapevolezza che ogni nostro pensiero e azione incide, tanto o poco che sia, nella costruzione della realtà.”
“Il registro elettronico è una sorta di tubo di cristallo trasparente che rende la scuola piú accessibile agli adulti; ciò fa sí che gli studenti non nascondano piú i voti o saltino le verifiche, e non per una loro libera e volontaria scelta, figlia di un confronto con la propria coscienza, ma in quanto controllati e monitorati. Senza libertà però non c’è responsabilità e senza responsabilità non c’è crescita personale. ”
“Ma crescere significa affrancarsi dagli adulti, litigare con essi e soprattutto diventare responsabili in prima persona delle proprie scelte e azioni. Ed essere adulti significa non rinunciare mai al proprio ruolo di educatori, pronti a mettersi in gioco e a discutere e a confrontarsi su che cosa sia giusto o no e su che cosa si possa o non si possa fare in un determinato contesto!”
“Vivere preparandosi alla morte significa cercare di abbellire di senso tutti i giorni che ci separano dall’appuntamento con la grande mietitrice. Non sapere quando la morte giungerà ci deve stimolare a guardare negli occhi la nostra vita e interrogarla su quello che vogliamo fare con essa.”
“Non c’è alternativa: per vivere liberi bisogna essere disposti a morire ogni giorno.”
Incipit del libro Anime fragili
1.
L’età della fragilità
I miei nonni si sono conosciuti nel 1943 tra le colline del Monferrato, in Piemonte, negli anni piú bui e duri della Seconda guerra mondiale. Erano due ragazzi di vent’anni travolti dalla Storia, quella collettiva, che sospinge le vite dei singoli verso orizzonti di gloria o di morte. Vite sospese tra speranze e illusioni.
Mio nonno, figlio di umili contadini, con la licenza di quinta elementare in tasca, dopo aver combattuto come alpino del Regio esercito italiano in Jugoslavia e aver vissuto sulla propria pelle l’assurdo orrore del conflitto, aveva scelto la strada della Resistenza contro il nazifascismo. Nome di battaglia: Leo. Mia nonna, invece, aveva abbandonato la città bombardata dagli Alleati e si era rifugiata in una casa in campagna, a cinquanta chilometri da Torino; decise di fare la staffetta partigiana per amore della libertà e di mio nonno. Fu un legame profondo, il loro, sino a quando la morte non li ha separati. Da quell’amore partigiano nacque, nell’Italia liberata, mia mamma.
I miei nonni hanno vissuto insieme per cinquant’anni, sempre a Chivasso, nel torinese, sempre nella stessa casa, via Rivera numero 3, rigorosamente in affitto, con contratto a equo canone. Mio nonno ha lavorato per trentacinque anni nelle Ferrovie dello Stato come aiuto macchinista: al termine del turno andava sempre nella stessa piola, dove beveva solo Barbera, giocando a carte, soltanto a briscola e a scopa. Non esistevano altri giochi. E quando tornava a casa trovava la cena preparata da mia nonna: primo, secondo, frutta, caffè e vino, ovviamente. La domenica c’erano anche gli antipasti, con il salame, cui seguiva il risotto, meglio se con i funghi, poi il bollito, con tanto di testina e bagnetto verde (prezzemolo, aglio e olio): lo stesso rito tutte le settimane dell’anno, esclusi i quindici giorni di vacanza estivi trascorsi sempre in campagna, a Cocconato, nel Monferrato.
Mia nonna ha accudito sua madre malata, cresciuto una figlia e fatto la magliaia per portare a casa qualche soldo per vivere un po’ meglio. I miei nonni hanno votato un unico partito per tutta la vita, e si è sciolto prima il partito del loro matrimonio. Da allora, per il nonno, votare non ha avuto piú lo stesso sapore e significato. Per lui i film da vedere erano i western, con Clint Eastwood e John Wayne, e quelli di guerra, e le sigarette da fumare erano le Nazionali verdi, senza filtro, pacchetto morbido in modo da tenerlo nella tasca della camicia o dei pantaloni. Giunta la pensione avevano deciso di provare il mare d’inverno e cosí per sette anni sono andati in Liguria, ovviamente stessa località, stessa casa, e stesso bar in cui bere il solito bicchiere di Barbera. Loro andavano d’inverno e io e i miei genitori d’estate: stessa spiaggia, stesso mare, stessa compagnia di amici. Poi all’improvviso arrivò la malattia, terribile, veloce e crudele; naturale e quasi scontata nel suo progredire, e del tutto indifferente alle sofferenze del corpo e dell’anima. Ma il punto di vista della malattia non è contemplato nel nostro stare al mondo. Io mi ero appena iscritto alla facoltà di Filosofia con il piccolo, grande sogno di fare l’insegnante. «Sarai il primo laureato e professore della nostra famiglia», mi aveva detto mio nonno.
Se vuoi ACQUISTA il libro