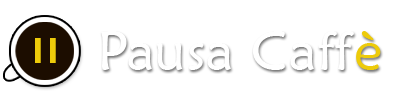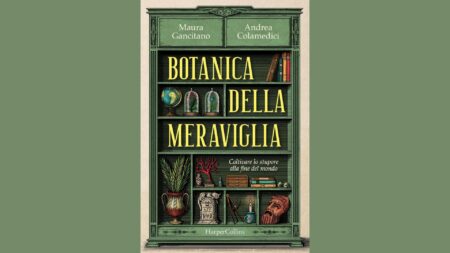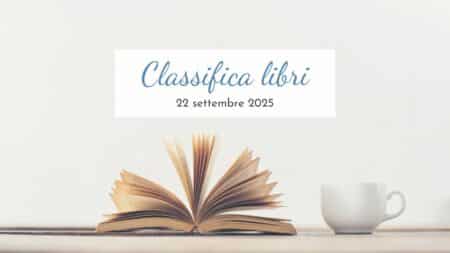La Flotilla per Gaza non è certo un’iniziativa nata ieri, né nel 2025. Per ritrovarne le radici dobbiamo tornare indietro nel tempo, fino al 2008, quando prese forma la prima idea di rompere simbolicamente, e concretamente, l’assedio che gravava sulla Striscia di Gaza. Ma, prima di imbarcarci in questo viaggio a ritroso, è necessario fermarsi un momento e ricostruire il quadro generale di quegli anni, perché senza comprendere il contesto storico e politico in cui tutto ebbe origine, sarebbe impossibile cogliere il senso profondo della Global Sumud Flotilla e del messaggio che porta con sé.
Gaza: la prigione a cielo aperto
Dal 2007, Israele ha imposto un blocco terrestre, aereo e marittimo sulla Striscia di Gaza. Un assedio che, nei fatti, ha trasformato quel lembo di terra in una prigione a cielo aperto. Non si trattava soltanto di limitare il passaggio delle persone, le restrizioni colpivano esportazioni e importazioni, rendendo difficilissimo accedere a cibo, sementi, mezzi agricoli e perfino combustibili.
Mentre a Gaza entravano con più facilità prodotti israeliani a basso costo, capaci di soffocare l’economia locale, le esportazioni palestinesi diventavano proibitive, schiacciate da controlli e requisiti doganali stabiliti da Israele. In pratica, i contadini si trovavano senza raccolto, senza mercato e senza futuro. E il mondo, salvo rare eccezioni, voltava lo sguardo altrove.
C’è poi un altro capitolo, meno noto ma ancora più inquietante, Israele dichiarò unilateralmente una vasta fascia di terra al confine come “no-go zone”, inaccessibile fino a 300 metri di distanza. Eppure, proprio lì si trovava gran parte delle terre coltivabili. Chi provava ad avvicinarsi veniva respinto con i fucili, a volte con esiti mortali. Non solo, ci furono coltivazioni sradicate, bestiame abbattuto persino a 700 metri di distanza. A questo si aggiunse la contaminazione da fosforo bianco usato nell’operazione “Piombo Fuso”, con il quale i terreni furono avvelenati, le falde compromesse, i pozzi bombardati. L’acqua, bene primario per ogni società agricola, diventava un miraggio.
Il quadro è quello di una strategia sistematica, non solo isolare un territorio già tra i più popolati del pianeta, ma colpirne il cuore pulsante, l’agricoltura. Gli effetti sono devastanti, povertà crescente, disoccupazione endemica, e un attacco diretto alla possibilità stessa di sopravvivenza autonoma.
E non basta ancora. Dal 2008, emerge l’esistenza di un vero e proprio “conteggio calorico”, un sistema calcolato per mantenere gli abitanti di Gaza su un livello di sussistenza appena sopra la soglia della fame. Nel frattempo, erbicidi, pesticidi e rifiuti tossici vengono dispersi quotidianamente sui terreni palestinesi, con l’obiettivo di rendere sterile ogni tentativo di coltivazione.
L’UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati, riesce a intervenire con pacchi alimentari trimestrali per alcune famiglie. Ma il paradosso, ancora una volta, è lampante, mentre un popolo viene privato del diritto a coltivare il proprio pane, si supplisce con l’assistenzialismo, come se si trattasse di una catastrofe naturale e non di una politica deliberata, condotta in violazione di ogni norma internazionale.
Il blocco navale: Gaza e il mare proibito
C’è un’altra barriera, meno visibile di un muro ma altrettanto soffocante: il blocco navale. Nessuna nave, nessuna barca può approdare nei porti di Gaza o entrare nelle sue acque territoriali, che si estendono per 11 miglia nautiche, circa 18 chilometri dalla costa. Un limite che, in realtà, non nasce oggi. Già negli anni Novanta, molto prima del 2008.
Mentre l’allontanamento per i pescherecci si è progressivamente ridotto, fino a concedere soltanto 6 miglia nautiche, appena 11 chilometri, ma chi conosce il mare sa bene che la pesca migliore si trova al largo, non sotto costa.
Per i pescatori palestinesi questo significò una condanna, si verificarono minacce, colpi di arma da fuoco, barche confiscate, reti strappate via. Risultato? La quantità di pesce pescato era più che dimezzata rispetto agli anni precedenti, fino al punto che il 90% dei 3.800 pescatori della Striscia viveva sotto la soglia della povertà. Gli episodi di fuoco aperto dalla marina israeliana contro le imbarcazioni palestinesi si contano a migliaia dal 2000, e dal 2022 la frequenza è diventata inquietante, almeno un attacco al giorno.
Ma il divieto non si limita alla pesca, fu persino vietato l’ingresso in mare, non solo con le barche, ma anche semplicemente per nuotare. Una regola che, in passato, Israele applicava a intermittenza, chiudendo un occhio in alcune occasioni, poi, dalla metà del 2025, il divieto è stato ribadito con durezza, da allora, la pesca e ogni attività in mare sono assolutamente proibite.
Eppure, la fame spinge oltre la paura. Alcuni pescatori, pur consapevoli del rischio, hanno continuato a uscire di nascosto, sperando di tornare con qualcosa da mettere in tavola. Ogni volta che prendono il largo, però, sanno di giocarsi la vita stessa.
La nascita della Flotilla per Gaza
Per capire come nacque la Flotilla per Gaza, bisogna guardare al 2008, fu allora che prese forma la Freedom Flotilla Coalition, una rete internazionale di attivisti con un obiettivo tanto semplice quanto dirompente, quello di rompere l’assedio israeliano e raggiungere le coste di Gaza dal mare.
La prima scintilla arrivò dal Free Gaza Movement, fondato da un gruppo di attivisti californiani. Due barche a vela, partite in momenti diversi, riuscirono davvero a toccare la costa di Gaza. Non perché l’assedio fosse cessato, ma perché, in quelle occasioni, l’esercito israeliano scelse di non fermarle. A bordo non c’erano armi né carichi militari, ma una quantità simbolica di materiale medico. In un caso, la barca ripartì portando con sé un giovane palestinese, vittima di una bomba, a cui era stata amputata una gamba, un gesto che fece il giro del mondo come testimonianza concreta di solidarietà.
Poi fu la volta della nave Dignity, che sempre nel 2008 riuscì a violare il blocco e ad approdare a Gaza. Quella spedizione portava con sé volontari internazionali e, tra loro, anche Vittorio Arrigoni, che avrebbe legato per sempre il suo nome e la sua vita alla causa palestinese.
In totale, tra il 2008 e il 2016, il Free Gaza Movement fece salpare ben 31 imbarcazioni dirette verso la Striscia. Solo una parte di esse riuscì a compiere l’impresa, ma ogni viaggio aveva lo stesso obiettivo, quello di testimoniare al mondo che quel blocco poteva, e doveva, essere sfidato. Tre furono le spedizioni rivendicate come un successo tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.
La Flotilla era ormai diventata un simbolo, piccole barche che, sfidando uno dei più potenti eserciti del mondo, cercavano di riportare a Gaza non solo aiuti, ma anche attenzione internazionale.
Il blocco navale e la tragedia della Mavi Marmara
I tentativi della Flotilla non rimasero senza conseguenze. Nel 2009, Israele decise di formalizzare il blocco navale, estendendolo fino a 20 miglia nautiche dalla costa, in pratica, l’intera linea marittima di Gaza diventava un’area proibita. Da allora, pattugliatori israeliani hanno sorvegliato senza tregua il rispetto del divieto, intervenendo non solo contro imbarcazioni provenienti dall’esterno, ma soprattutto contro i pescatori locali, spesso aprendo il fuoco sulle loro barche.
Poi arrivò la data che avrebbe cambiato tutto, il 31 maggio 2010. Sei imbarcazioni della Gaza Freedom Flotilla salparono con un obiettivo dichiarato, rompere il blocco e raggiungere Gaza. L’iniziativa era stata organizzata dal Free Gaza Movement e dalla ONG turca Humanitarian Relief Foundation (IHH), proprietaria della nave ammiraglia della spedizione, la Mavi Marmara. Quella nave era un gigante, con quasi 600 persone a bordo e un carico che includeva 10mila tonnellate di cemento, destinato a ricostruire case e infrastrutture distrutte.
La risposta di Israele fu immediata e violenta. Motovedette ed elicotteri dell’esercito assaltarono la flotta in acque internazionali. A bordo della Mavi Marmara, circa quaranta passeggeri opposero resistenza attiva, arrivando a catturare temporaneamente tre soldati. La reazione militare fu durissima, i colpi d’arma da fuoco uccisero nove persone sul colpo, otto cittadini turchi e un americano di origini turche. Una decima vittima morì dopo quattro anni di coma.
Le indagini successive, condotte in Turchia, gettarono ombre ancora più pesanti, alcune delle persone uccise riportavano ferite da arma da fuoco alla testa, compatibili con esecuzioni a distanza ravvicinata. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite non usò mezzi termini, l’assalto israeliano alla Mavi Marmara fu definito «sproporzionato», «brutale» e, soprattutto, una violazione del diritto internazionale.
Da quel giorno, la parola “Flotilla” smise di essere soltanto il simbolo di un atto di solidarietà internazionale, diventò un caso politico e diplomatico, un punto di rottura nelle relazioni tra Israele, la Turchia e gran parte della comunità internazionale.
La Freedom Flotilla II e le scuse di Israele
Dopo la tragedia della Mavi Marmara, la mobilitazione non si fermò. Nel 2011 prese forma la Freedom Flotilla II, organizzata da una vasta coalizione di ONG e attivisti provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo era sempre lo stesso, rompere il blocco israeliano e portare aiuti umanitari a Gaza. Questa volta erano in gioco più di dieci imbarcazioni e oltre trecento partecipanti.
Ma la macchina diplomatica di Israele si mosse con largo anticipo. Pressioni politiche, sabotaggi misteriosi alle navi e la decisione del governo greco di vietare la partenza bloccarono quasi tutta la flotta prima ancora che potesse lasciare il Mediterraneo orientale (vi ricorda qualcosa?).
Alla fine, solo una barca a vela riuscì a salpare, la Dignité-Al Karama, battente bandiera francese, con a bordo 17 passeggeri. Ufficialmente diretta verso un porto egiziano, dichiarò in un secondo momento la sua vera destinazione, cioè Gaza. Ma non arrivò mai, fu intercettata in acque internazionali dai commando della marina israeliana, fu trainata fino al porto di Ashdod, gli li attivisti vennero arrestati, trattenuti per breve tempo e poi espulsi.
Due anni dopo, nel 2013, Israele tentò di chiudere la ferita aperta con la Turchia. Arrivarono le scuse ufficiali per gli “errori operativi” (anche qui vi ricordano qualcosa?) commessi durante l’assalto alla Mavi Marmara. Un accordo di risarcimento rimase però a lungo sospeso, mentre in Turchia alcuni soldati e funzionari israeliani coinvolti nell’attacco furono processati in contumacia per crimini di guerra.
La seconda Flotilla, quindi, non riuscì a raggiungere il suo obiettivo, ma lasciò un segnale chiaro, nonostante la sorveglianza israeliana e gli ostacoli diplomatici, la volontà di sfidare l’assedio non si era spenta.
La Freedom Flotilla III e la campagna del 2015
Il 2015 segnò un nuovo capitolo nella sfida all’assedio. La Freedom Flotilla III, organizzata ancora una volta dalla Freedom Flotilla Coalition (FFC), prevedeva diverse imbarcazioni, con la Marianne, battente bandiera svedese, come nave di punta.
Il 29 giugno 2015, a circa cento miglia nautiche dalla costa di Gaza, quindi ancora in acque internazionali, la missione fu intercettata dalle forze navali israeliane. Un commando salì a bordo della Marianne e la dirottò verso il porto di Ashdod, tutti gli attivisti furono arrestati, alcuni vennero espulsi in tempi rapidi, mentre altri, membri dell’equipaggio, furono trattenuti per sei giorni prima di essere rilasciati.
La Flottiglia del 2018 e gli ultimi episodi
La campagna “Just Future for Palestine”, conosciuta anche come Flottiglia per la libertà di Gaza del 2018, fu una delle più ambiziose iniziative della Freedom Flotilla Coalition. L’operazione comprendeva due navi principali, la Al Awda (“Il Ritorno”) e la Freedom, sostenute da due yacht, la Mairead e la Falestine.
Il 29 luglio e il 3 agosto 2018, entrambe le navi principali furono intercettate dalla marina israeliana in acque internazionali. Gli attivisti a bordo vennero arrestati, alcuni denunciarono di essere stati colpiti con il taser, aggrediti e picchiati dai militari israeliani. La maggior parte dei partecipanti rimase in stato di detenzione per alcuni giorni, prima di essere espulsa nei paesi di origine.
Un episodio ancora più oscuro avvenne poco prima, il 2 maggio 2018, la nave Conscience, diretta verso Gaza, fu colpita due volte da droni armati (vi ricorda qualcosa?), a circa 14 miglia nautiche dalla costa di Malta. L’attacco provocò un incendio a bordo e la rottura dello scafo, costringendo i trenta attivisti a lottare contro il rischio di naufragio, quattro persone rimasero ferite, riportando ustioni gravi.
E non è finita qui. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno di quell’anno, un’altra barca della FFC, con dodici attivisti a bordo, è stata nuovamente fermata dalle forze armate israeliane. Un segnale inequivocabile, il braccio di ferro tra chi cerca di rompere l’assedio e chi intende mantenerlo è tutt’altro che concluso.
Un filo rosso continuava a legare queste spedizioni, piccole imbarcazioni civili, con a bordo attivisti da tutto il mondo, che sfidavano apertamente uno dei blocchi militari più ferrei del pianeta. Ogni missione veniva fermata, spesso con la forza, ma ogni volta l’assedio di Gaza tornava sotto i riflettori internazionali.
Gaza dopo il 7 ottobre 2023
Prima che il mondo precipitasse nella spirale di violenza successiva al 7 ottobre 2023, la Striscia di Gaza contava circa 2,3 milioni di abitanti stipati in uno dei territori più densamente popolati del pianeta. Da anni era già stata definita la più grande prigione a cielo aperto del mondo.
Poi, con l’operazione militare israeliana scatenata in risposta all’orribile attacco terroristico di Hamas, la situazione si è trasformata in una catastrofe senza precedenti. Oggi i numeri parlano da soli, e sono numeri che gelano il sangue: oltre 64.000 morti, di cui 25.000 bambini.
La Commissione d’Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite ha stabilito un punto fermo che pesa come un macigno: Israele ha commesso un genocidio contro il popolo palestinese.
La Global Sumud Flotilla
Il 7 settembre 2025, dal porto di Catania, è salpata ufficialmente la Global Sumud Flotilla. Un’operazione civile e non governativa, nata per esprimere solidarietà concreta al popolo palestinese della Striscia di Gaza.
Il nome stesso porta con sé un significato profondo: ṣumūd, in arabo, significa “resilienza”. E proprio di resilienza si parla guardando a questa flottiglia, con più di 50 imbarcazioni, con partecipanti provenienti da 44 paesi diversi, che hanno lasciato i porti di Barcellona, Genova, Tunisia, Catania e Siro in Grecia, per convergere verso Gaza.
La stampa internazionale l’ha già descritta come il più grande convoglio marittimo civile della storia. Una carovana sul mare, composta da barche di ogni dimensione, unite da un unico scopo, quello di sfidare il blocco e riportare l’attenzione mondiale su questa tragedia che troppo spesso in passato è stata relegata ai margini, che oggi si è trasformato in massacro, in genocidio, e non possiamo più mettere sotto il tappeto.
E anche se la Flotilla non dovesse mai riuscire nell’impresa epica di raggiungere Gaza via mare, resta il fatto che ogni partecipante ha già navigato in un mare di giustizia, scegliendo di esporsi in prima persona per una causa più grande.
Come scrisse Vittorio Arrigoni, che di queste missioni fece parte e che continua a rappresentarne lo spirito:
“Non ho perso tempo,
ho tirato su martello e chiodi,
e dal mio zaino ho estratto due libri, Murales e Memoria contro l’oblio.
Li ho piantati a prua delle Free Gaza e della Liberty,
saranno la prima cosa che si troveranno di fronte i militari israeliani,
se cercheranno di arrestare la nostra missione umanitaria.
Saranno i versi di Darwish la nostra polena
e nessuna impresa sarà mai troppo epica con la sua poetica come esorcismo al terrore della morte violenta.
Versi e prose per rimanere umani quando la guerra riduce l’essere umano
a una poltiglia di contaminante odio.”
E il suo monito, più che mai attuale, resta inciso come bussola morale per tutti: Restiamo umani.
Trovate molte fonti sul web
Dovreste leggere gli articoli di Vittorio Arrigoni nell’archivio storico de Il Manifesto